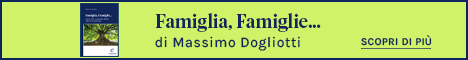
1. Fondo patrimoniale - 2. Trust - 3. Vincolo di destinazione - NOTE
[1] Il fondo patrimoniale è un istituto, che trova la sua previsione e disciplina nel Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione II agli artt. 167 ss. c.c. Rientrando nelle convenzioni patrimoniali della famiglia è comunque soggetto, oltre che alla disciplina specifica sopra citata, anche alle disposizioni generali contenute nel Capo VI, Sezione I (art. 159 ss.). Si tratta, nella specie, di uno strumento introdotto dalla Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, che consente a ciascun coniuge (o entrambi) o ad un terzo di vincolare determinati beni (mobili, immobili o iscritti in pubblici registri) ai “bisogni della famiglia” (quali il soddisfacimento di diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione), dando origine ad una sorta di “patrimonio separato”. Va, innanzitutto, precisato che esso non costituisce un tertium genus di regime patrimoniale della famiglia, alterativo rispetto a quelli della comunione legale e separazione dei beni, bensì un “mero” vincolo di destinazione di determinati beni, che si inserisce in uno di questi due regimi “di base”, e che sottopone i beni in esso ricompresi ad una peculiare disciplina di amministrazione, con limiti dispositivi da parte dei costituenti (es. vincoli di alienabilità) e nei confronti dei terzi creditori (limiti di espropriabilità). Nella realtà, esso si rivela soprattutto utilizzato a fini di tutela del patrimonio familiare da possibili azioni dei creditori per debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, eventualmente svolta da uno dei coniugi; al contempo, bisogna riconoscersi che tale scopo può esporlo ad un “indebito” utilizzo, quale quello teso a sottrarre fraudolentemente beni in danno di creditori e/o dell’erario. Analizziamo, dunque, nello specifico la regolamentazione dell’istituto de quo. A) Natura giuridica e costituzione Il fondo patrimoniale, essendo destinato, come detto, a rappresentare un “patrimonio separato” della famiglia, in quanto volto al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della stessa, gode di una particolare disciplina, finalizzata a garantire la realizzazione dello scopo (soddisfacimento dei bisogni, appunto, della famiglia), con la previsione di vincoli da parte dei coniugi (i quali non possono disporre dei beni oggetto dello stesso per [continua ..]
[3] Il trust rappresenta un’ipotesi particolare di patrimonio separato ed è un istituto di derivazione anglosassone recepito nell’ordinamento italiano non con una regolamentazione diretta dello stesso, bensì con l’adesione dello Stato italiano alla Convenzione dell’Aja (di seguito, per semplicità, “Convenzione”), stipulata il 1° luglio 1985, in forza della legge di ratifica 16 ottobre 1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1982. Il trust è uno strumento di segregazione del patrimonio o di parte dei beni di un soggetto (disponente o settlor) posto sotto controllo di un altro soggetto (trustee);più precisamente, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora determinati beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Conv.). In virtù della Convenzione dell’Aja, sono riconosciuti all’interno dell’ordinamento italiano sia i trust nazionali – che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche i trust cc.dd. interni, che non presentano cioè alcun elemento di estraneità con l’ordinamento italiano né di carattere oggettivo (beni conferiti in trust) né di carattere soggettivo (disponente e trustee), ad eccezione della legge applicabile all’istituto quale unico elemento di estraneità tra il trust e l’ordinamento italiano. È opportuno, prima di entrare nel merito delle modalità operative del trust di cui, in ogni caso, non esiste un rigido ed unitario modello, individuarne i soggetti principali coinvolti, i beni interessati e le tipologie principali. A) Soggetti Nel trust possono individuarsi tre categorie di soggetti: il disponente (o settlor o grantor), il trustee (l’amministratore/gestore) e i beneficiari (beneficiary), che possono essere individuati in modo preciso o generico (come categoria di soggetti); solo eventuale è la presenza di un quarto soggetto, il guardiano (protector), nominato dal disponente. In particolare: Il disponente [continua ..]
L’art. 2745 ter, inserito nel nostro codice civile dall’art. 39 novies della l. n. 53/1936, prevede che si possa creare con atti in forma pubblica dei vincoli di destinazione su beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri (o, come vedremo, su beni mobili non registrati a determinate condizioni), un vincolo di destinazione per realizzare interessi meritevoli di tutela per persone disabili o pubbliche amministrazioni o persone fisiche. Tali atti devono essere trascritti per rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e la norma in parola prevede che per la realizzazione degli interessi meritevoli possa agire oltre al conferente i beni da destinare, qualsiasi interessato durante la vita del conferente. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e non possono essere esecutati se non per debiti contratti per lo scopo (realizzazione dell’interesse meritevole) cui sono destinati, a meno che, come previsto dall’art. 2915 c.c., gli atti esecutivi non siano stati trascritti prima del vincolo di destinazione. La stranezza legislativa è data dal fatto che si è deciso di disciplinare gli atti negoziali di destinazione solo con la previsione della trascrivibilità del relativo vincolo, per cui si è utilizzata una norma sulla pubblicità introducendo nella stessa anche una norma sulla fattispecie. In buona sostanza detta norma ha natura sostanziale e introduce appunto la categoria giuridica degli atti di destinazione negoziale. Qualche autore ha parlato di “norma dalla doppia anima”. In generale per vincolo di destinazione si intende una situazione giuridica soggettiva secondaria di contenuto negativo, che assolve la funzione di conservare la destinazione convenzionalmente o normativamente impressa ad uno o più beni. I beni “destinati” sono oggettivamente vincolati allo scopo e possono essere utilizzati solo per il conferimento del fine di destinazione. Con tale vincolo si realizza un “effetto segregativo”, come previsto dall’ultima parte della norma che esclude la soggezione all’esecuzione dei beni stessi, talché si realizza una limitazione della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740, 2° comma, c.c. Tant’è che, come già accennato, ai creditori [continua ..]