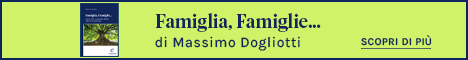
- 1. Riflessioni sulla l. n. 219/2012 - 2. Dalla potestÓ alla responsabilitÓ genitoriale - 3. Ascolto del minore - 4. Affidamento a terzi - 5. Parentela e cognome - NOTE
Nelle giornate del 9 e 10 maggio 2014 si è tenuta a Napoli l’Assemblea Nazionale dell’AIAF, volta ad analizzare e discutere l’applicazione della recente riforma introdotta dalla l. n. 219/2012 e dal successivo d.l. n. 154/1913. Nella riunione del gruppo di lavoro sugli aspetti sostanziali della riforma sono emerse varie posizioni, in particolare in ordine ai seguenti temi: responsabilità genitoriale, ascolto del minore, affidamento del minore a terzi ex art. 337 bis. Molto preziosi sono stati gli interventi del Presidente dott. Gustavo Sergio, del dott. Geremia Casaburi, del dott. Giacinto Bisogni e della dott. Monica Velletti, in veste, quest’ultima, anche di membro della Commissione Bianca, che si è occupata della redazione del testo di legge e che ha offerto anche un suo contributo specifico che di seguito si pubblica. Il gruppo di lavoro si era dato l’obbiettivo anche di affrontare altri temi, quali ad esempio quello della parentela, ma la disponibilità sostanzialmente di una sola giornata di lavoro ha reso impossibile un’analisi integrale sul punto. Il par. 5 di questa sintesi è stato curato interamente dalla collega Remigia D’Agata, Presidente dall’AIAF Sicilia, in merito ai rapporti di parentela e alle norme regolatrici del cognome.
I lavori sono subito iniziati con la indicazione di diverse criticità che la nuova normativa presenta, ed è emerso che la legge manca di un presupposto fondamentale, ossia la revisione dell’istituto del matrimonio e la disciplina analitica in tema di famiglia di fatto e ciò comporta che ancora non vi sia stato un miglioramento del tutto organico nella materia della filiazione e che tuttora sussistano alcune disparità tra figli nati da una coppia coniugata e i figli nati fuori dal matrimonio. Solo disciplinando legislativamente le coppie di fatto ci potrà essere effettivamente una riforma completa dell’istituto della filiazione. Altra criticità che è emersa nel corso dei lavori è stata quella del mancato superamento della presunzione di paternità ed è stato evidenziato che il legislatore ha mantenuto differenziate le modalità di attribuzione dello stato di filiazione e di formazione del relativo titolo dello stato, a seconda del legame matrimoniale o meno dei genitori. Pertanto, anche dopo la riforma, il matrimonio attribuisce in automatico lo stato di figlio e ciò consente al legislatore di stabilire la presunzione di paternità; al contrario, in mancanza di matrimonio tra i genitori, l’accertamento dello stato di figlio avviene solo con un atto volontario, ossia il riconoscimento ex art. 250 c.c. o un accertamento giudiziale ex art. 269 c.c. Per quanto riguarda la presunzione di maternità, è emerso che si sta cercando di colmare l’attuale vuoto legislativo, in special modo alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 278/2013 che ha stabilito il diritto del figlio di poter legittimamente ricercare le proprie origini genitoriali. Infatti, allo stato, se la madre non è coniugata, la sua identità non può essere indicata nell’atto di nascita del figlio, salvo che la stessa renda di persona la dichiarazione di riconoscimento. Alla luce di tali differenziazioni ancora in auge, il legislatore ha voluto imporre un termine di decadenza per poter impugnare il riconoscimento, per ciò che riguarda la legittimazione attiva dei genitori o di terze persone legittimate; la riforma ha stabilito un termine di decadenza di cinque anni per le azioni di stato, trascorso il quale nessuno può più mettere in discussione il riconoscimento, salvo il figlio medesimo. Si [continua ..]
La l. n. 219/2012, all’art. 2 aveva delegato il Governo ad unificare le disposizioni che riguardavano i figli nati dentro o fuori dal matrimonio fissando nella lett. h) «l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto della potestà genitoriale». Ciò è avvenuto sicuramente anche raccogliendo gli stimoli giunti nel nostro Paese in questi anni dalle Convenzioni internazionali e dalle pronunce nazionali e sovranazionali. È stato pertanto chiesto al legislatore delegato che, nei futuri decreti legge, fosse rivisto, in tutti i codici e le leggi in materia, il concetto di potestà, delineando quello di “responsabilità genitoriale”, lontano dalla passata connotazione di potere e più in sintonia con l’esigenza di cura e di attenzione da prestare al minore [1]. Si è pensato che lo sguardo si dovesse volgere al minore, i cui genitori sono oggi più che mai costituzionalmente obbligati a mantenerlo, istruirlo ed educarlo, nonché, ai sensi del nuovo art. 315 bis c.c., a far sì che lo stesso cresca in famiglia, mantenga rapporti significativi con i parenti, sia ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano quando abbia compiuto gli anni dodici, e anche in età inferiore ove capace di discernimento. Il nuovo art. 315 bis c.c., nell’introdurre la relazione diretta genitori-figli, pone, all’interno della norma stessa, i predetti diritti, ma anche i doveri dei figli: «Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». L’art. 316 c.c., novellato al 4° comma, contiene probabilmente un eccesso di delega, per l’introduzione tout court del termine e del concetto di responsabilità genitoriale, poiché enuncia la norma: «Il genitore che ha riconosciuto il figlio, esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi». Occorre [continua ..]
In tema di ascolto del minore, è subito emerso che occorre essere piuttosto cauti in questi primissimi tempi di applicazione della nuova normativa e che occorra ancora riferirsi ai protocolli emessi dai vari Tribunali – argomento sul quale il dibattito è aperto, anche in relazione alla loro validità, a seguito della nuova norma. In ogni caso, la pietra miliare è e rimane la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Allo stato attuale, ad una prima prudente valutazione, parrebbe che la giurisprudenza di legittimità interpreti l’art. 336 bis c.c. nel senso di non ritenere obbligatorio l’ascolto del minore da parte del giudice, salvo una motivazione puntuale sulla scelta di non procedervi. È emerso anche che la questione terminologica non è irrilevante e che va valorizzata la scelta precisa del legislatore nell’individuare l’“ascolto” al posto de l’“audizione” e che il primo luogo di ascolto del minore è e deve essere la famiglia. Il giudice deve disporre di tale strumento solo se è strettamente necessario e con le dovute cautele (come l’utilizzo di spazi adeguati, videoregistrazioni, e\o l’ausilio di psicologi di sostegno).
La discussione all’interno del gruppo di studio si è concentrata in modo particolare sul tema delicatissimo dell’affidamento a terzi. Si è reso necessario tentare un excursus comparativo con la realtà precedente, al fine di poter comprendere a pieno la portata delle novità introdotte. Il punto di partenza dell’analisi dell’istituto dell’affidamento a terzi, è, come di consueto, quello normativo. L’art. 155 c.c. è ora stato sostituito dal d.lgs. n. 154/2013 che ha convogliato la tutela della prole negli artt. 337 ss., applicabile a tutti i figli nati fuori e dentro il matrimonio. In particolare, l’art. 337 ter c.c., dopo avere sancito, nel 1° comma, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, aggiunge, nel secondo capoverso, che per realizzare la finalità indicata dal 1° comma, nei procedimenti di cui all’art. 337 bis c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. La norma valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. In secondo luogo, l’art. 337 bis c.c. stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine, copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. In sostanza, la novità dell’art. 337 bis c.c. rispetto al [continua ..]
La novella del 2012 ha determinato un cambiamento non indifferente in quelli che sono i rapporti di parentela, ampliando le relazioni ed attribuendo “la parentela” anche ai figli nati fuori dal matrimonio, mentre in precedenza tale qualifica era solo per i figli nati dentro il matrimonio. L’ambito di maggior incidenza è certamente quello successorio: infatti, detto ampliamento rende successibili nei confronti degli ascendenti, anche i figli nati fuori dal matrimonio, prima esclusi. Oltre a ciò, la riforma incide anche sulle conseguenze legate al diritto – dovere di assistenza e di accudimento dei figli. La citata parificazione di status ricomprende anche i figli adottivi, ad eccezione dell’adozione di maggiorenni che sottostà a specifica normativa che esclude detto requisito. Il problema si pone invece per i minori adottati ai sensi dell’art. 44, l. n. 84/1983, cioè per l’adozione in casi particolari; ciò in quanto, in questi casi, i minori non perdono la relazione di parentela con la famiglia d’origine e verrebbero così a trovarsi ad essere successibili di più nuclei familiari (adottivo e d’origine). La dottrina sul punto ha espresso varie posizioni e quella che pare maggiormente condivisibile è quella che vuole equiparare i casi di adozione in casi particolari all’adozione per maggiorenni, escludendo così il rapporto di parentela. Ma se appunto questo orientamento può essere condiviso nei casi riportati alla lett. d) dell’art. 44 l. adozione, potrebbe non esserlo nei casi di cui alle lett. a), b), c), invero nei casi in cui il minore sia privo di legami parentali d’origine o nel caso di adozione del coniuge del genitore, in cui si verrebbe a creare una disparità di trattamento con eventuali altri figli ed altresì una mancanza di tutela del minore nell’escluderlo dalla parentela degli adottanti. Peraltro l’art. 74, come novellato, parla solo dell’adozione legittimante e non anche degli altri casi di adozione che ne resterebbero esclusi. Sarebbe, dunque, auspicabile una previsione che tenga conto, anche in caso di adozione ex art. 44, di particolari situazioni in cui il requisito della parentela potrebbe essere consentito (ad esempio, nel caso di minori orfani o nel caso dell’adozione del coniuge del genitore). Per quanto riguarda la normativa [continua ..]